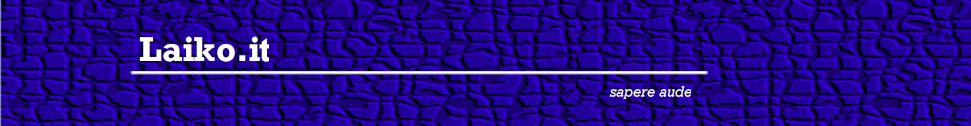Intervista a Carlo Alberto Defanti
Carlo Alberto Defanti, neurologo, docente di Bioetica presso la Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è attualmente uno dei più accredidati esperti italiani nel campo delle problematiche sul fine vita. Ha pubblicato rilevanti contributi sul problema medico della definizione di morte e sulle sue implicazioni operative, con particolare attenzione alle decisioni che riguardino soggetti che non hanno formalizzato direttive anticipate di trattamento. La sua riflessione ha ben presente da un lato i rischi della soggezione ad un puro tecnicismo, dall’altro i non giustificati condizionamenti dell’etica confessionale. A lui ho posto alcune domande su argomenti di interesse per l’UAAR.
F. D’Alpa: Prof. Defanti, Lei è noto al grande pubblico per una aspra battaglia contro l’accanimento terapeutico nei soggetti in stato vegetativo persistente. Le sue convinzioni sono oggi più solide oppure ha qualche ripensamento?
C. A. Defanti: Mi permetta di formulare qualche critica sulla sua domanda, che a mio giudizio non è posta del tutto correttamente. Da tempo vado criticando il concetto stesso di accanimento terapeutico: una formula efficace sul piano della comunicazione, ma assai poco chiara nei suoi contenuti, tanto è vero che tutti – a partire dal magistero cattolico – si dichiarano contrari all’accanimento terapeutico, mentre poi intendono con questo termine cose molto diverse. Per fare chiarezza, credo che si debbano distinguere due situazioni: (a) la prima è quella di una persona capace di intendere e di volere: essa ha il diritto di rinunciare a qualsiasi trattamento sanitario, indipendentemente dal tipo di trattamento. Il principio è sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Dunque, se una persona è in grado di decidere per sé, sia nell’attualità, sia in previsione di malattia durante la quale non sarà più capace di farlo, il concetto di accanimento terapeutico non ha alcun rilievo e la persona ha il diritto di rinunciare anche a trattamenti potenzialmente salvifici; (b) la seconda situazione è quella di una persona che si trovi in stato di malattia e di incapacità decisionale e che non si sia pronunciata in precedenza in merito ai suoi trattamenti futuri. Qui manca l’elemento cruciale della decisione individuale e il problema diviene quello di capire se questi trattamenti siano o meno appropriati nella situazione clinica data. Solo in questi casi l’idea dell’accanimento terapeutico potrebbe essere rilevante. Ma occorre chiedersi: appropriati rispetto a che cosa? Un trattamento è o non appropriato rispetto al fine che si propone. Se il fine è il prolungamento della vita a qualsiasi costo, ogni trattamento è appropriato, salvo quelli del tutto inefficaci. Se il fine è la guarigione della malattia o quanto meno il miglioramento/la salvaguardia della qualità della vita, molti trattamenti non sono appropriati. Nel caso specifico dello stato vegetativo, la nutrizione artificiale non è inappropriata se il fine è il prolungamento della vita, mentre lo è certamente se il fine è la guarigione o il miglioramento della qualità di vita. In ultima analisi, il problema non risolto è quello degli scopi delle cure. Semplice se il malato si è espresso (definendo, esplicitamente o non, questi scopi), rimane aperto se non lo ha fatto. La decisione allora deve essere presa dai medici in concerto con coloro che rappresentano il paziente, per lo più i familiari. Un aiuto potrebbe essere dato dalle società scientifiche, che sono probabilmente le fonti più autorevoli di giudizio sull’appropriatezza delle cure, ma la decisione poi va presa caso per caso, tenendo conto delle situazioni di ciascun individuo.
Tornando ora alla Sua domanda, nel caso di Eluana Englaro ciò che il padre ha sostenuto – ed io l’ho appoggiato per quanto ho potuto e lo rifarei in un caso analogo – non è che la nutrizione artificiale fosse un “accanimento terapeutico”, ma semplicemente che Eluana avrebbe rifiutato questo tipo di trattamento. Mi scuso per la lunghezza della risposta, ma mi sembra che così si chiariscano le cose.
F.D.: Secondo il suo parere, il principio della disponibilità piena e cosciente della propria vita (come espressa nelle dichiarazioni anticipate di trattamento) deve essere soggetto, anche in condizioni estreme d’esistenza, a limiti o eccezioni di legge?
C.A.D.: Credo che una buona legge sia necessaria, anche per evitare che altre persone debbano affrontare il calvario dei genitori di Eluana. La legge dovrebbe prevedere che il paziente formuli le sue direttive in condizioni di piena capacità, testimoniata da due persone, che possa in ogni momento modificarle, possibilmente che nomini contestualmente un fiduciario con cui i medici possano concertare le decisioni da prendere, dato che esiste un largo margine di imprevedibilità sul futuro (sanitario e non) di chiunque.
F.D.: Vite sempre più lunghe equivalgono spesso a prolungamento di esistenze soggettivamente ritenute inaccettabili e non degne. La medicina non sta forzando troppo la natura?
C.A.D.: La medicina procede per tentativi ed errori e di molte cure che sono diventate routinarie, specie in passato, siamo debitori a medici e ricercatori che hanno compiuto degli “azzardi” fortunati. Forzare la natura è espressione metafisica che non amo: a ben guardare, tutta la nostra vita di esseri civili è basata su siffatte “forzature”.
F.D.: Fino all’introduzione delle tecniche rianimatorie e di supporto vitale, il morire era solo una breve fase di passaggio fra la vita e la morte, non più arrestabile dall’intervento medico. Oggi è invece possibile limitare o arrestare questo processo, anche per un lungo periodo. Ma nei soggetti in morte cerebrale è ancora legittimo parlare di persistenza della persona? In che senso siamo ancora di fronte, in questi casi, ad un essere totalmente umano e non solo ad una macchina biologica?
C.A.D.: Anche a questo proposito si pone il problema dei fini della medicina. La rianimazione è nata con un solo scopo chiaro: salvare/prolungare la vita. C’è riuscita e ci riesce in molti casi, ma la sua azione ha creato situazioni inedite – come la cosiddetta morte cerebrale – che ci pongono di fronte a nuove responsabilità. E’ chiaro che davanti ad un individuo in morte cerebrale lo scopo delle cure viene meno e che è nostra responsabilità prenderne atto e smettere il trattamento di sostegno vitale.
F.D.: A dispetto delle crescenti certezze della medicina, la definizione di morte clinica oggi è sempre più in discussione. E’ solo una ricaduta della tecnica, o piuttosto il segno di un maggiore rispetto verso l’individuo?
C.A.D.: Le difficoltà che attraversa oggi il concetto di morte cerebrale non sono, in realtà, nuove. Il fatto è che nel 1968, quando questa idea fu formulata, i medici di Harvard preferirono decidere di dare una definizione scientifica (identificando quella condizione clinica con la morte) piuttosto che aprire un dibattito etico che avrebbe coinvolto anche altri problemi, come la stessa eutanasia. Oggi però questo escamotage è sempre più in crisi e probabilmente bisognerà prima o poi riconoscere che la soluzione trovata a suo tempo, pur essendo complessivamente buona e utile, deve essere sostituita con un’altra, che tenga conto del fatto che, in ultima analisi, il problema è di ordine morale piuttosto che scientifico.
F.D.: Il recente dibattito sulla presunta conservazione di attività ‘mentali’ in soggetti con diagnosi di stato vegetativo persistente impone, in base ad un principio di prudenza, una rivisitazione del giudizio di irreversibilità e dunque di legittima interruzione del sostegno vitale? Fino a che punto la pratica medica può o deve risentire attualmente di queste osservazioni, in attesa di convincenti conferme?
C.A.D.: Si è voluto impropriamente sfruttare le nuove conoscenze per combattere la battaglia di Beppino Englaro per liberare sua figlia, ma si tratta di piani di discorso del tutto distinti. Un conto è la battaglia per affermare il diritto di ognuno a decidere per sé e un altro la ricerca medica sui disturbi cronici di coscienza, un campo che trovo affascinante e che certamente comporterà una rivoluzione nei nostri metodi di assistenza e soprattutto un miglioramento della nostra capacità di prognosi.
F.D.: Tradizionalmente, nell’assistenza medica al morente vigeva un limite oltre il quale il processo del morire veniva ritenuto inarrestabile, e dunque lo si accettava come inevitabile. Tale pratica è tuttora sostanzialmente la regola nel caso dell’assistenza sanitaria extraospedaliera. In ambiente ospedaliero invece è frequente (anche per sollecitazione dei familiari) un grado variabile di accanimento terapeutico, nonostante un auspicato orientamento deontologico secondo il quale le pratiche rianimatorie andrebbero riservate a quei pazienti per i quali è lecito sperare in una ripresa. Ciò non configura una forzatura impropria (in molti casi in accordo con un atteggiamento confessionale) dell’etica medica?
C.A.D.: Rimando alla mia prima risposta.
F.D.: La bioetica cattolica sembra avere perso di vista l’opzione del soprannaturale e si configura sempre più come una sorta di riserva morale sulle scelte mediche prettamente laiche. Lei ritiene che la teologia abbia ancora una sua coerenza in tema di scelte di fine vita, ovvero che faccia sempre riferimento a quei propri principi che ritiene ‘inviolabili’?
C.A.D.: Non sono certo un teologo, ma sono convinto che la tendenza attuale della teologia morale cattolica, tutta incentrata sull’inviolabilità della vita, sia soprattutto un modo che la Chiesa ha di affermare il proprio potere politico e che, sia pure in tempi lunghi, essa sarà superata in una direzione più sostenibile.
F.D.: A suo parere, le istanze dei bioeticisti laici troveranno finalmente accoglienza, nonostante l’attuale clima politico non favorevole, nel nostro ordinamento giuridico?
C.A.D.: Sono molto dubbioso, credo che in questo clima politico non si possa giungere a nulla di buono sul piano legislativo