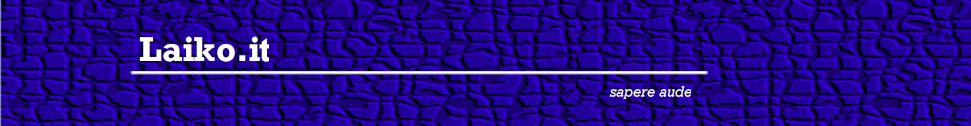La morte e il suo timore
A sentire i moniti papali, viviamo in una ‘cultura di morte’ (ma votata all’edonismo, al disprezzo ed alla relativizzazione dei ‘Valori’ autentici, ovvero cristiani) nella quale il pensiero che ognuno dovrebbe fare della propria ed altrui fine è purtuttavia scotomizzato, occultato; a differenza di quanto accadrebbe in seno alla Chiesa.
“Magna cogitatio”, ovvero “il gran pensiero dell’Eternità”. Per secoli il mondo cristiano ne ha fatto una ossessione: vivere in attesa della morte e del ‘giudizio finale’, l’inappellabile sentenza: dentro o fuori la grazia di Dio? La morte è infatti passaggio decisivo nella vita del cristiano, più dello stesso nascere. Perché da quel momento, per la pagella dell’anima, è ‘game over’: “Dove caderà in morte l’albero dell’anima tua, ivi avrai da restare in eterno. E non vi è via di mezzo, o sempre re nel cielo, o sempre schiavo nell’inferno” [1].
Non è dunque un caso che uno dei più letti testi del cristianesimo sia dedicato al tema della morte: “L’apparecchio alla morte, cioè Considerazioni sulle massime eterne, del beato Alfonso M. de’ Liguori” (prima edizione 1758, con innumerevoli ristampe e traduzioni).
Oggi quasi si fatica ad immaginare una società così compenetrata dalla religione, come quella del tempo in cui visse il nostro autore; nella quale la sua ricca personalità, la sua profonda cultura religiosa e la sua abilità discorsiva erano capaci di incidere profondamente sulla vita dei sinceri credenti.
Alfonso de’ Liguori era soprattutto un grande moralista; ogni spunto teologico si traduceva inevitabilmente in lui in imperativo obbligo morale, in precetto di vita. E cosa può toccare maggiormente l’animo umano della morte, della paura del morire, e (per i cristiani) del morire in peccato?
A noi non credenti, come insegnavano gli epicurei, razionalmente, la morte non dovrebbe incutere paura, perché non ha senso temere il passaggio al nulla. Ma se si crede invece che la morte sia transito in un’altra vita, nella quale persiste l’Io individuale (sia pure in modalità inimmaginabile), allora questo ignoto angoscia. Ancor più se nell’oltrevita ci attende un severo padre padrone. Peggio ancora se questo nuovo stato resta fissato, immutabile, in eterno.
Il pensiero della morte obbliga (o almeno obbligherebbe) il buon cristiano a porsi quella che potremmo in qualche modo definire una questione di ‘qualità della vita’: meglio godere per poco oggi e soffrire in eterno domani, o viceversa (visto che sembra quasi impossibile, secondo i Vangeli, che il ricco guadagni il paradiso)? La risposta non può essere altro che quella invariabile della catechesi: memento mori, ricordati che devi morire e che tutto il ‘dopo’ dipende da come ti presenterai al cospetto del creatore.
In questo senso, la logica di Alfonso de’ Liguori è stringente: “Sarebbe pazzo quel pellegrino, che passando per un paese volesse ivi impiegare tutto il suo patrimonio, per comprarsi ivi una villa, o una casa, che tra pochi giorni avesse poi a lasciare” [2]. Il monito riecheggia Agostino di Ippona ed in ultima analisi la parabola evangelica del ricco Epulone [Luca 16: 19-31]; ed è uno dei concetti più usuali del predicatore napoletano.
Perché costruirsi una casa ricca se poi non se ne potrà godere in eterno? In una società in cui la vita presentava continue insidie, nella quale la sopravvivenza a malattie anche banali era incerta, e dove l’età media era pari a quella dei paesi del terzo mondo attuale, cosa poteva consolare maggiormente del pensiero di ottenere un giorno, e per sempre, quel benessere mai o per poco goduto?
L’ossessione della morte aveva un tempo un pesante risvolto pratico, essendo in perfetta simbiosi con quella del peccato che “ingiuria Dio, lo disonora, l’amareggia” [3]. All’uomo cristiano, secondo Alfonso de’ Liguori, non si addice la “pazzia del peccatore”. Per questo egli raccomanda: rinunzia agli onori, rinunzia alle ricchezze, privazione dei piaceri dei sensi, disprezzo delle “scienze mondane”; al loro posto, amore della solitudine, vita umile e nascosta [4]. Ma soprattutto, abbandono alla volontà divina: “Procuriamo al presente di soffrir con pazienza le afflizioni di questa vita, offerendole a Dio in unione delle pene che patì Gesù Cristo per nostro amore; e facciamoci animo con la speranza del Paradiso” [5]. Ma quali saranno i beni di questo paradiso? Nessuno in realtà ce lo può dire, giacchè “non abbiamo altre idee che de’ beni di questa terra” [5].
Certamente ci sarà infine un premio: ad esempio, l’anima del trapassato avrà la consolazione di ritrovare quei cari già defunti che l’hanno preceduta nel paradiso, laddove “non vi è cosa che dispiaccia, ed è tutto quello che piace” [5]. A nostro avviso, ovviamente, nulla più che una pia illusione.
Tutto questo indaffararsi ha origine dal fatto che il cristianesimo, andando oltre la primitiva tradizione ebraica, dà per scontata l’esistenza di un ‘prima’ e di un ‘dopo’. La vita individuale è creduta un sistema a due comparti, senza vera contrapposizione fra vita e morte, ma solo cambiamento di scena. L’anima, l’Io, sono ritenuti persistenti, in perfetta continuità temporale, sebbene abitanti in tempi diversi due corpi diversi, l’uno materiale, l’altro immateriale.
Ma l’Io del ‘prima’, protestiamo, è concreto: pensa, desidera, sceglie. Quell’altro invece? L’aldilà cristiano immagina ciò che al senso comune appare del tutto impossibile: essere al tempo stesso, e per l’eternità, ciò che si è stati (come ‘Io’) e ciò che si diviene, senza perdere l’essenza intima del ‘prima’. Ma dopo il momento critico del trapasso, potrebbe davvero persistere ciò che caratterizza attualmente l’Io psico-fisico individuale? Non sarebbe meglio, per gli spiritualisti, immaginare in alternativa un ritorno nel ‘tutto’, come ipotizzavano gli atomisti? Del quale ritorno, in definitiva, non ci importerebbe granché.
L’attaccamento di Alfonso de’ Liguori, come di qualunque altro predicatore, al tema ‘morte’ può però avere altre e più semplici motivazioni. La morte infatti è per l’uomo comune innanzitutto ‘paura del morire’; e la paura è una delle emozioni fondamentali. Si ha paura di un pericolo reale, ma si può instillare altrettanta paura prefigurando un pericolo immaginario; in tal modo si può influire, con la propria autorità, sul comportamento delle persone, le si può affascinare con le proprie soluzioni al problema. Chiudendo il cerchio, quale migliore mezzo della catechesi sulla morte e sulle angosce collegate, per appecorare i fedeli? Dunque, catechesi a beneficio non proprio dei fedeli ma della Chiesa stessa, che come sappiamo ben monetizza la paura del purgatorio e dell’inferno.
Si può sostenere che, in genere, la paura spinga a comportamenti adattativi, dunque ad ‘agire meglio’. Ma è vero in tal caso? O piuttosto, la paura della morte non spinge il buon credente a privarsi dei più che legittimi piaceri della vita?
Applicandola alla lettera, la prospettiva liguoriana dovrebbe in effetti portare all’inazione. Ma di mezzo c’è l’uomo reale, che è ben altra cosa. Di certo, Alfonso de’ Liguori non intende imporre a tutto il suo uditorio il pauperismo; e non può augurarsi che ogni giovane prenda la tanto elogiata ‘via del deserto’. Per questo, al di là delle figure retoriche, la sua predicazione va colta realisticamente soprattutto come un mezzo per moderare le passioni, specie nei più sottomessi; ed in questo è perfettamente contestualizzata nei luoghi e nel tempo.
Cosa dire, invece, della paura paralizzante dell’infermo, sperimentata in particolare dai mistici? Quella paura che è all’origine di tante estasi, di tante ‘possessioni’, di tante condotte insensate, di tante sofferenze (in buona parte autoinflitte) patite in nome (e nel desiderio) di un ipotetico futuro non-soffrire, secondo la scommessa pascaliana? Quante vite dilaniate, in questo caso, da ciò che è artatamente instillato nella coscienza!
Il mondo moderno, con il suo benessere ha fortunatamente reso desueti o addirittura stravolto alcuni concetti della tradizione cristiana: pensiamo ad esempio alla ‘buona morte’, che per i catechisti equivaleva in passato al solo morire ‘in grazia di dio’; e che invece oggi, per i più, equivale al morire in dignità e senza inutile sofferenza, possibilmente in modo istantaneo e quasi a comando. Ciò non significa esorcizzare la morte, come ritengono i preti, ma dare importanza unicamente alla vita ben vissuta. Il pensiero della morte e del giudizio finale, non è d’altra parte risultato bastevole a rendere migliori legioni di credenti; e noi non ne abbiamo bisogno per costruire una soddisfacente etica.
Riferimenti:
[1] Alfonso M. de’ Liguori, L’apparecchio alla morte, Considerazione XIV, punto II]
[2] idem, Considerazione XIV, punto I
[3] idem, Considerazione XV, punto I
[4] idem, Considerazione XX, punto I
[5] idem, Considerazione XXIX, punto I