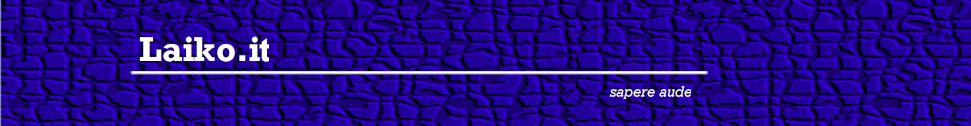Lucien Israël
Contro l’eutanasia
Lindau, Torino, 2007
Euro 13.00
ISBN 978-88-7180-671-6
Questo volume, senz’altro fuori tema rispetto al dibattito cui sembra riferirsi il titolo, non affronta quasi per nulla il delicato tema della legittimità di porre fine deliberatamente e consapevolmente (ma sempre per gravissime ragioni) alla propria vita, come discusso recentemente in Italia a proposito dei casi Coscioni e Welby.
La pratica cui quasi esclusivamente l’autore si riferisce ha rapporto piuttosto con l’eugenetica, con l’eliminazione dei non autosufficienti, ormai inutili alla società, o, peggio, dei malati e dei ‘diversi’. In tal senso, la sua posizione di “non credente” (o meglio di “agnostico”) appare a mio avviso assolutamente irrilevante, ed impropriamente evidenziata in copertina: giacché chi rimpiange la perduto dell’uso di termini come ‘anima’, ‘dio’, ‘bene’, ‘giusto’, va piuttosto inquadrato come ‘credente pratico’.
Ricollegandoosi ad un passato che a suo dire possedeva ‘valori’ oggi perduti e derisi, Israël dimentica che proprio le società pregne di valori ‘collettivi’ (o addirittura metafisici) comprimevano più di altre quelli individuali (in particolare la vita stessa del singolo); che solo le società moderne hanno finalmente assicurato (almeno formalmente) all’anziano ed al non autosufficiente una migliore qualità di vita, in tutti i sensi; e che in definitiva l’uomo era meno rispettato nel suo vero essere (come lo concepiamo oggi) proprio quando veniva affidato alla ‘provvidenza’ cristiana o all’arbitrio di una qualche divinità.
Ma veniamo a quanto ci riguarda più da vicino. Israël ritiene che “sarà sempre concesso, a chi lo voglia, di richiedere di non essere curato”, ad esempio “quando si sa che non ci sarebbe alcun beneficio nel proseguire una cura che infliggerebbe al paziente solo tormenti”. Ma ciò non è esattamente quello che sostengono, in campo avverso, quanti vengono giornalmente bollati dagli ecclesiastici e dai loro corifei come sostenitori della cosiddetta ‘cultura di morte’?
Afferma inoltre che l’eutanasia passiva in caso di morte cerebrale è oggi accettata anche dalle autorità religiose: cosa assolutamente non vera.
E sostiene perfino che “se una persona vuole uccidere il coniuge perché crede che sia l’unico modo di porre fine alle sue sofferenze, e questa decisione non esce dalle mura domestiche, la faccenda non mi riguarda. Non sarei per perseguire legalmente il responsabile”. In che termini dunque egli difende, in assoluto, la vita?
Israël, in ultima analisi, definisce l’eutanasia “una richiesta che proviene dalle persone sane che vogliono disfarsi di un malato grave o in fase terminale”, uno “strumento sociale” per risolvere problemi pratici; dunque la richiesta di eutanasia “corrisponde all’affermazione di un materialismo nudo e crudo” (ma intanto segnala che, secondo la sua esperienza, i credenti non si pongono di fronte alla morte in atteggiamento diverso dai non credenti).
Certo non è questo il panorama attuale nella società occidentale; e non è su questo che si dibatte fra i bioeticisti. La richiesta dei non credenti (di coloro che ritengono che la vita sia realmente un valore solo quando, e fin quando, è ‘umana’), è invece sempre e solo quella di vivere al meglio fino a dove si può e di essere lasciati liberi di farla finita con le sofferenze laddove ciò è divenuto impossibile o ci si è trasformati in inutili appendici di una macchina. Tale richiesta non appare minimamente delegittimata, anzi sembra perfino supportata, da questo contraddittorio contributo.