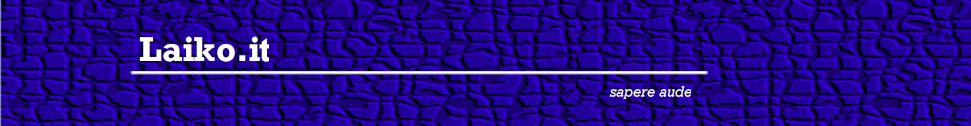La rotondità eccedente e l’eccedenza rotonda
di Francesco D’Alpa
Nella presentazione del numero 4/2005 di MicroMega, Paolo Flores d’Arcais, mentre conviene sulla ormai ovvia considerazione che, in tema di natura umana, la filosofia è obbligata “a fare i conti con la scienza, anzi a riconoscere che la scienza ha eguale (almeno) diritto a pensare il tema con i suoi strumenti”, dall’altra afferma che il “classico tema dell’animale culturale […] viene al mondo quando la scimmia si fa uomo”, a causa di quella “vera e propria rottura, che quell’1 per cento di dna modificato, che quei pochi centimetri quadrati di corteccia fanno irrompere nella storia della vita”[1].
E così ecco riaffacciarsi il vecchio pregiudizio antropocentrico sulla separazione netta fra umanità e natura, non lontano dall’argomento teologico del salto ontologico, qui riformulati entrambi come ‘eccedenza’: dell’uomo rispetto all’animale, chiuso nella ‘rotondità’ (ovvero nella definitezza e ‘perfezione’) del suo essere. Né più né meno ciò che per i teologi costituirebbe la insuperabile differenza ‘qualitativa’ fra l’essere animato dallo spirito e l’animale ‘senza anima’.
L’idea illustrata da Flores d’Arcais nel suo articolo [2] (come ben sottolinea Maria Turchetto in questo stesso numero dell’ATEO), appare quanto mai strana: aperta alle scienze moderne nelle premesse, ma di fatto disconnessa dalle attuali conoscenze scientifiche sulla oggettiva natura dell’uomo e degli animali. Una discrepanza evidente anche rispetto a molti degli altri contributi presenti nello stesso numero di MicroMega.
Partiamo dall’assunto generale: “l’uomo è l’animale eccedente”. L’eccedenza non è (o non è solo), per Flores d’Arcais, il ‘di più’ che distingue l’uomo dall’animale, quanto la possibilità dell’uomo di eccedere se stesso, nel senso del possesso e dell’esercizio di una ‘libertà’ non limitata da alcuna ‘rotondità’ (come invece accadrebbe nei non umani).
L’impressione che ne ho, è che Flores d’Arcais mescoli indebitamente argomenti diversi. Che l’uomo abbia sviluppato una cultura che gli ha permesso di superare la sua originaria (rotonda?) animalità è un dato di fatto, ma oltre ciò manifesta davvero una eccedenza? E questa eccedenza, se così la vogliamo definire, mancherebbe negli altri animali? Pensiamo a qualche esempio banale: le prime fondamentali ‘scoperte’ di alcuni uomini primitivi (la gestione del fuoco, la cottura del cibo, l’invenzione della ruota, etc.) sono manifestazioni di ‘ordinaria’ eccedenza? Assolutamente no, se riflettiamo sull’enorme tempo occorso per acquisire e stabilizzare ognuna di queste primissime tappe della civilizzazione. Ma queste conoscenze sono state trasmesse (e vengono trasmesse) con facilità all’intera popolazione dei simili: il che dimostra che esiste (ed è sempre esistita) nella ‘cerebralità’ umana (geneticamente determinata) una ampia possibilità di padroneggiare fenomeni e manufatti. Una eccedenza o una norma, per la specie?
Ma anche nel mondo animale, ce lo insegna l’etologia, avviene qualcosa di simile: scimmie che scoprono come (o imparano a) lavare le patate, che si ingegnano a costruire piccoli attrezzi per procurarsi il cibo, che apprendono il linguaggio umano dei segni. Animali, in buona sostanza, che sembrerebbero non avere iscritte nel loro repertorio istintuale queste abilità, ma che hanno nel loro cervello la capacità di padroneggiarle, oltre che di apprendere ciò che non è istintivo osservando i propri simili o addirittura gli umani. Una eccedenza anche questa dunque, secondo il ragionamento di Flores d’Arcais; a meno di non considerare quella dell’uomo una non-eccedenza. In realtà, sembrano insegnarci l’etologia e l’antropologia, il repertorio delle possibilità ‘biologiche’ di ogni specie è molto più esteso di quello che si evidenzia nel comportamento ‘naturale’ (in assenza di sollecitazioni dall’esterno) della specie, e alcuni singoli possono talvolta spontaneamente mettere in campo qualcosa di nuovo che dunque ‘eccede’ ciò che è consuetudinario ma senza eccedere per questo le possibilità finora inespresse della specie: una sorta di ‘exaptation’ culturale (usando il linguaggio di Flores d’Arcais: in ogni rotondità c’è eccedenza, ed ogni eccedenza è comunque a sua volta rotondità).
Una seconda obiezione a Flores d’Arcais è l’inaccettabile contrapposizione fra istinto e ragione: l’animale sarebbe inesorabilmente confinato entro i limiti del suo istinto, nella circolarità fra bisogno e suo soddisfacimento, al di fuori della quale non avrebbe sostanzialmente motivazioni all’agire. Prescindendo dal fatto che la stessa circolarità sembra appartenere (senza fargliene una colpa) a buona parte dell’umanità attuale (e probabilmente anche l’umanità primitiva non eccedeva questa circolarità), attribuire agli animali tale limite contrasta perfino con il comune buon senso. L’animale infatti, già quando osservato nel suo habitat naturale, ma ancor più se in cattività o meglio se convivente con l’uomo, palesa incredibili ‘eccedenze’: comprende gli stati d’animo del suo padrone, elabora strategie, addirittura (secondo alcuni) ha un suo senso della vita e della morte e perfino una sorta di istinto religioso. L’animale può facilmente essere addestrato, in palese eccedenza alla sua natura. Taluni animali possono sembrare più intelligenti dei meno intelligenti fra gli uomini. Ma, in tutto questo, l’animale resta sempre sé stesso; la sua rigida ‘circolarità’ è dunque solo apparente. C’è in sua vece un insieme di istinto e libertà, come nell’uomo. L’istinto animale è al massimo una ‘ragione inferiore’; laddove si potrebbe anche sostenere che la ragione umana sia una specie di istinto superiore (a David Hume, ad esempio, il ragionamento sperimentale appariva già null’altro che un tipo d’istinto). La differenza fra uomo e animale non è dunque, ancora una volta, qualitativa (l’avere o no una ‘eccedenza’), ma piuttosto il ‘quantum’ di questa eccedenza (o ‘circolarità’).
Terza considerazione: allo schema bisogno-istinto-soddisfacimento sfuggono la curiosità ed il gioco, ben evidenti negli animali, a dimostrazione del fatto che l’apprendimento non avviene solo quando conduce ad una riduzione del bisogno (come invece sostenevano gli psicologi sperimentali della prima metà del Novecento). Gli animali, come l’uomo, ‘desiderano’ sperimentare certe impressioni e provare determinate esperienze, anche se queste non sono finalizzate ad una ricompensa; possono essere semplicemente interessati, e dunque creativi; anzi, paradossalmente, proprio la possibilità di avere un premio (solitamente il cibo) può ridurre la loro curiosità. Anche gli animali sono tendenzialmente portati ad eccedere il loro repertorio istintuale, ad ampliare le proprie conoscenze, e verosimilmente ad organizzare le proprie esperienze, rimodellando continuamente (come avviene nell’uomo) i propri schemi comportamentali: dunque ‘impadronendosi’, nelle proprie rappresentazioni mentali, del mondo che li circonda e gettandosi ‘oltre’ lo spazio finora conosciuto. In ciò non v’è alcuna ‘eccedenza’ ma piuttosto una sofisticata versione della straordinaria capacità di tutti i viventi di adattarsi all’ambiente e di sopravanzare il repertorio dei comportamenti geneticamente predeterminati.
Un quarto punto da contestare è l’ipotesi che la religione (o quanto meno la religiosità) sia un prodotto culturale specifico dell’eccedenza. Qui entriamo assolutamente nel campo della filosofia e della teologia; mi riferisco ad una certa rappresentazione dell’uomo religioso (anzi, meglio, cristiano) per ‘natura’ (“anima naturaliter christiana”, secondo Tertulliano), immerso (ma non confondibile ed in assoluto contrasto con esso) nel mondo del non umano (che costituirebbe solo il teatro in cui si svolge l’avventura umana). A turbare le idee degli spiritualisti, l’ipotesi di una religiosità animale faceva comunque parte delle credenze del mondo antico, ed addirittura era contemplata nella stessa Bibbia (secondo il Salmo 148 anche le fiere e tutte le bestie in genere lodavano il Signore); ed una certa tradizione cristiana successiva non era estranea a questi concetti (san Francesco d’Assisi predicava agli uccelli; il cavallo di sant’Antonio da Padova si sarebbe piegato sulle ginocchia per ricevere l’ostia!). Ma queste idee (direi meglio: questa percezione della vicinanza animale-uomo) è comunque rimasta sempre ai margini (o fuori) dell’ortodossia. Ci voleva Darwin per riportare autorevolmente in campo l’idea (scomoda per gli uomini del suo tempo) che linguaggio e coscienza non sono prerogative umane e che anche gli animali manifestano un chiaro atteggiamento di devozione nel loro affetto verso il padrone.
Francamente non vedo ragioni per proporre, sotto mentite spoglie, da parte di Flores d’Arcais, una contrapposizione che nel pensiero occidentale ha sempre avuto forti connotati teologici, ma pochi riscontri oggettivi una volta sottoposta al vaglio delle scienze naturali. E poi, riflettiamoci bene, affermare che l’animale abbia una propria circolarità non equivale in fondo a sostenere che egli sia una macchina? Perché solo una macchina è incapace di funzionare (di comportarsi) al di fuori del suo schema di funzionamento. Ed invece gli animali sanno fare cose diverse o anche contrarie (come rinunciare al cibo) a quelle direttamente derivanti dal loro istinto, e addirittura provano a farle: secondo Friedrich Engels “chiunque abbia sovente a che fare con questi animali riuscirà difficilmente a sottrarsi alla convinzione che, in un gran numero di casi, essi si sentano effettivamente frustrati per non riuscire a parlare, sebbene purtroppo si tratti di un difetto cui non si può porre rimedio” [3]. Riconoscere queste capacità non è una concessione ingiustificata ad una ideologica umanizzazione dell’animale, quanto piuttosto una ulteriore presa d’atto dell’unità dei viventi, le cui caratteristiche non conoscono precise barriere di specie. La recente individuazione dei ‘neuroni specchio’ ha ad esempio dimostrato definitivamente che anche gli animali sono in grado di comprendere l’intenzionalità altrui (ed ha dunque rimosso un ulteriore tassello della supposta specificità umana).
Che gli animali (all’interno della propria specie) abbiano un carattere ed una personalità individuali, una variabile intelligenza ed una ampia gamma di qualità morali è acquisizione definitiva soprattutto degli ultimi secoli. Che tali caratteristiche siano ampiamente distribuite e sovrapposte fra le varie specie animali (incluso l’uomo) è acquisizione scientifica ancora più recente (anche se, come già detto, non ignota ‘da sempre’ al senso comune, al punto da essere enfatizzata da un vero e proprio genere letterario, che attraversa i secoli almeno a partire dal cane di Ulisse). Che l’animale avesse un suo universo morale lo sapevano bene gli antichi scrittori di favole, che non a caso utilizzavano analogie e metafore animali nelle loro narrazioni.
Ancora una volta (ma non è un caso) dobbiamo attribuire agli scrittori ed agli apologeti cristiani un grosso demerito nell’avere compiuto fondamentali passi indietro nel riconoscimento di questa comune ‘animalità’ dei viventi: a partire ad esempio dal libro dell’Apocalisse, secondo il quale nel giorno della Resurrezione finale i cani e tutti gli animali impuri saranno esclusi dalla Gerusalemme celeste; il che veniva tradotto nella predicazione comune nell’affermazione della inesistenza di una anima immortale negli animali.
Concludendo, non posso non domandarmi perché, dopo che un numero crescente di intellettuali e scienziati ha sentito da qualche secolo in qua il dovere di abbattere le barriere che separavano concettualmente (almeno in certe concezioni del mondo, ed in particolare in quella cristiana) la ‘animalità’ dalla ‘umanità’, un pensatore darwinista e laico marci oggi (almeno apparentemente) in senso opposto: forse un soprassalto della ragione umana pungolata nel suo orgoglio? O un infortunio!
Bibliografia
[1] MicroMega, n. 4/2005, pp. 4 e 6
[2] Paolo Flores d’Arcais, La natura dell’esistenza (1). Appunti per una filosofia del finito. MicroMega, n. 4/2005, pp. 239-262.
[3] Citato in: Keith Thomas, L’uomo e la natura. (ed. it) Einaudi 1994, p. 117.